 L’indio, elemento chimico che viene riconosciuto universalmente con il simbolo In e il numero atomico 49, appartiene al terzo gruppo del sistema periodico; la sua presenza è davvero molto modesta sulla crosta terrestre, ma comunque esso è distribuito in un gran numero di minerali e, in particolare, in quelli di zinco che ne contengono fino allo 0,1%. Proprio per questo motivo, la sua produzione industriale parte dai minerali di zinco; la purificazione finale dell’indio (fino al 99,9% per la precisione) viene in genere eseguita attraverso l’elettrolisi in un ambiente piuttosto acquoso. Tra l’altro, tale metallo è anche molto tenero e possiede la proprietà unica di aderire ad altre superfici quando vi viene strofinato. La temperatura di fusione supera i 156 gradi, mentre quella di bollitura deve essere necessariamente superiore ai duemila gradi.
L’indio, elemento chimico che viene riconosciuto universalmente con il simbolo In e il numero atomico 49, appartiene al terzo gruppo del sistema periodico; la sua presenza è davvero molto modesta sulla crosta terrestre, ma comunque esso è distribuito in un gran numero di minerali e, in particolare, in quelli di zinco che ne contengono fino allo 0,1%. Proprio per questo motivo, la sua produzione industriale parte dai minerali di zinco; la purificazione finale dell’indio (fino al 99,9% per la precisione) viene in genere eseguita attraverso l’elettrolisi in un ambiente piuttosto acquoso. Tra l’altro, tale metallo è anche molto tenero e possiede la proprietà unica di aderire ad altre superfici quando vi viene strofinato. La temperatura di fusione supera i 156 gradi, mentre quella di bollitura deve essere necessariamente superiore ai duemila gradi.
Prodotti industria chimica
Gli impieghi e le produzioni industriali dei mastici
 La produzione industriale dei mastici, un tempo piuttosto empirica, si è sempre più orientata verso un impiego piuttosto specifico su qualsiasi tipo di materiale con cui si può avere a che fare. È quindi utile distinguere quali sono le tipologie principali in questo senso, in modo da comprenderne l’utilità e le differenze. Un esempio molto interessante è offerto senza dubbio dai cosiddetti “mastici a freddo”. In pratica, si tratta di quelle soluzioni industriale dense e a base di caucciù, oppure di resine sintetiche e di solventi di natura organica: la classica presentazione che possiamo rinvenire in commercio è quella dei tubetti che sono pronti all’uso, visto che il loro impiego peculiare riguarda il caso domestico e quello artigianale. Al contrario, i mastici a fusione sono quelli che prevedono una composizione a base di cera lacca, colofonia, coppale e pece.
La produzione industriale dei mastici, un tempo piuttosto empirica, si è sempre più orientata verso un impiego piuttosto specifico su qualsiasi tipo di materiale con cui si può avere a che fare. È quindi utile distinguere quali sono le tipologie principali in questo senso, in modo da comprenderne l’utilità e le differenze. Un esempio molto interessante è offerto senza dubbio dai cosiddetti “mastici a freddo”. In pratica, si tratta di quelle soluzioni industriale dense e a base di caucciù, oppure di resine sintetiche e di solventi di natura organica: la classica presentazione che possiamo rinvenire in commercio è quella dei tubetti che sono pronti all’uso, visto che il loro impiego peculiare riguarda il caso domestico e quello artigianale. Al contrario, i mastici a fusione sono quelli che prevedono una composizione a base di cera lacca, colofonia, coppale e pece.
Le miscele industriali denominate Dowtherm
 Il nome “dowtherm” è quello che è stato registrato per due tipi distinti di miscele, le quali sono costituite da particolari liquidi organici: l’utilizzo in questione, inoltre, è quello relativo ai mezzi per la trasmissione di calore ad alta temperatura. Di quali miscele si tratta per la precisione? I due liquidi che sono caratterizzati da questo termine specifico sono il Dowtherm A e il Dowtherm E. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Il Dowtherm A è la miscela eutettica (il punto di fusione è più basso di quello dei singoli elementi che la compongono) che è costituita al 73,5% in peso di ossido di difenile e dal 26,5% di difenile vero e proprio. Si tratta di un mix molto stabile, il quale viene impiegato per quelle temperature che sono comprese tra i duecento e i quattrocento gradi.
Il nome “dowtherm” è quello che è stato registrato per due tipi distinti di miscele, le quali sono costituite da particolari liquidi organici: l’utilizzo in questione, inoltre, è quello relativo ai mezzi per la trasmissione di calore ad alta temperatura. Di quali miscele si tratta per la precisione? I due liquidi che sono caratterizzati da questo termine specifico sono il Dowtherm A e il Dowtherm E. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Il Dowtherm A è la miscela eutettica (il punto di fusione è più basso di quello dei singoli elementi che la compongono) che è costituita al 73,5% in peso di ossido di difenile e dal 26,5% di difenile vero e proprio. Si tratta di un mix molto stabile, il quale viene impiegato per quelle temperature che sono comprese tra i duecento e i quattrocento gradi.
Industria chimica e farmaceutica: l’acqua distillata
 Quando è necessario avere a disposizione dell’acqua che sia assolutamente priva di ogni tipo di sostanza disciolta, si ricorre in maniera molto frequente alla cosiddetta distillazione: questa procedura viene seguita molto spesso nell’industria chimica e in quella farmaceutica, ma non bisogna nemmeno dimenticare i laboratori. Come si procede in questo senso? Anzitutto, un distillatore viene ad essere costituito da un’apposita caldaia, il recipiente in cui viene fatta bollire l’acqua e che viene collegata anche al cosiddetto refrigerante. Quest’ultimo, poi, è costituito da un tubo che è generalmente avvolto a serpentino, circondato da un tubo ancora più largo o manicotto, attraverso il quale circola dell’aria fredda.
Quando è necessario avere a disposizione dell’acqua che sia assolutamente priva di ogni tipo di sostanza disciolta, si ricorre in maniera molto frequente alla cosiddetta distillazione: questa procedura viene seguita molto spesso nell’industria chimica e in quella farmaceutica, ma non bisogna nemmeno dimenticare i laboratori. Come si procede in questo senso? Anzitutto, un distillatore viene ad essere costituito da un’apposita caldaia, il recipiente in cui viene fatta bollire l’acqua e che viene collegata anche al cosiddetto refrigerante. Quest’ultimo, poi, è costituito da un tubo che è generalmente avvolto a serpentino, circondato da un tubo ancora più largo o manicotto, attraverso il quale circola dell’aria fredda.
I metodi industriali per la preparazione del cloro
 Il cloro, elemento chimico oggi così noto, fu ottenuto per la prima volta in assoluto nel 1774: ritenuto dapprima un composto ossigenato, fu poi riconosciuto come elemento del Davy nel 1810 e la sua denominazione deriva dal greco, volendo indicare soprattutto il colore verde. Si tratta a tutti gli effetti del più importante e diffuso degli alogeni, con il composto principale che non è altro che il comune sale da cucina, vale a dire il cloruro di sodio. Il cloro può essere preparato attraverso degli opportuni metodi di laboratorio, visto che si ottiene andando a trattare una soluzione di acido cloridrico con una sostanza ossidante, ovvero capace di fornire ossigeno allo stato atomico o nascente.
Il cloro, elemento chimico oggi così noto, fu ottenuto per la prima volta in assoluto nel 1774: ritenuto dapprima un composto ossigenato, fu poi riconosciuto come elemento del Davy nel 1810 e la sua denominazione deriva dal greco, volendo indicare soprattutto il colore verde. Si tratta a tutti gli effetti del più importante e diffuso degli alogeni, con il composto principale che non è altro che il comune sale da cucina, vale a dire il cloruro di sodio. Il cloro può essere preparato attraverso degli opportuni metodi di laboratorio, visto che si ottiene andando a trattare una soluzione di acido cloridrico con una sostanza ossidante, ovvero capace di fornire ossigeno allo stato atomico o nascente.
Lavorazione del tabacco, ma non solo: l’industria della nicotina
 Tutti sanno perfettamente che una delle componenti essenziali delle sigarette è la nicotina: ma in che modo l’industria chimica riesce a ottenere questo importante alcaloide? Quest’ultimo si trova essenzialmente nelle piante del genere denominato “Nicotiana”, il quale fa a sua volta parte delle Solanacee. Fra queste, una delle più importanti è senza dubbio la Nicotiana Rustica, che ne è particolarmente ricca, con delle percentuali comprese tra il 5 e il 14%. In aggiunta, la nicotina viene prodotta anche in maniera artificiale attraverso delle sintesi. L’industria della nicotina si fonda in pratica sull’utilizzo di cascami e residui della lavorazione del tabacco: la sua estrazione viene compiuta per mezzo della lisciviazione dei cascami stessi, con dell’acqua in controcorrente in una batteria di diffusori.
Tutti sanno perfettamente che una delle componenti essenziali delle sigarette è la nicotina: ma in che modo l’industria chimica riesce a ottenere questo importante alcaloide? Quest’ultimo si trova essenzialmente nelle piante del genere denominato “Nicotiana”, il quale fa a sua volta parte delle Solanacee. Fra queste, una delle più importanti è senza dubbio la Nicotiana Rustica, che ne è particolarmente ricca, con delle percentuali comprese tra il 5 e il 14%. In aggiunta, la nicotina viene prodotta anche in maniera artificiale attraverso delle sintesi. L’industria della nicotina si fonda in pratica sull’utilizzo di cascami e residui della lavorazione del tabacco: la sua estrazione viene compiuta per mezzo della lisciviazione dei cascami stessi, con dell’acqua in controcorrente in una batteria di diffusori.
Chimica industriale: come ottenere la chamotte
 Il termine chamotte è molto diffuso nell’industria chimica per indicare la polvere che si può ottenere attraverso una opportuna macinazione dell’argilla: quest’ultima, in particolare, viene cotta fino a quando non si consegue una disidratazione perfetta e completa. Il suo impiego industriale più diffuso è quello relativo allo smagrimento delle argille grasse, in modo da diminuire la plasticità delle stesse, la quale sarebbe altrimenti causa, oltre che di un ritiro piuttosto forte, anche di una estrema porosità del prodotto cotto. Gli scarti di lavorazione e il cotto in questione che si è frantumato nel trasporto finiscono poi per macinazione una ottima chamotte. Tra l’altro, quest’ultima può essere prodotta in modo adeguato anche dal caolino, la roccia sedimentaria che è formata essenzialmente da caolinite, vale a dire uno dei minerali silicatici dell’argilla.
Il termine chamotte è molto diffuso nell’industria chimica per indicare la polvere che si può ottenere attraverso una opportuna macinazione dell’argilla: quest’ultima, in particolare, viene cotta fino a quando non si consegue una disidratazione perfetta e completa. Il suo impiego industriale più diffuso è quello relativo allo smagrimento delle argille grasse, in modo da diminuire la plasticità delle stesse, la quale sarebbe altrimenti causa, oltre che di un ritiro piuttosto forte, anche di una estrema porosità del prodotto cotto. Gli scarti di lavorazione e il cotto in questione che si è frantumato nel trasporto finiscono poi per macinazione una ottima chamotte. Tra l’altro, quest’ultima può essere prodotta in modo adeguato anche dal caolino, la roccia sedimentaria che è formata essenzialmente da caolinite, vale a dire uno dei minerali silicatici dell’argilla.
Industria chimica: i coloranti
 I coloranti sono quelle sostanze capaci di tingere un supporto, in cui penetrano e si fissano da sole o per azione di altre sostanze (dette anche “mordenti”). Si devono quindi distinguere dai colori come i pigmenti e le lacche, i quali tingono per effetto della sovrapposizione, formando uno strato colorato sul supporto stesso. I coloranti sono quasi tutti di natura organica e vengono distinti in naturali (vegetali o animali) e artificiali. Gli utilizzi industriali sono davvero molti, in particolare si possono citare la stampa e la colorazione dei tessuti e dei filati, la colorazione dei prodotti organici, l’utilizzo nella fotografia, nella microscopia e anche in qualità di indicatori. Le categorie di coloranti sono sostanzialmente quattro.
I coloranti sono quelle sostanze capaci di tingere un supporto, in cui penetrano e si fissano da sole o per azione di altre sostanze (dette anche “mordenti”). Si devono quindi distinguere dai colori come i pigmenti e le lacche, i quali tingono per effetto della sovrapposizione, formando uno strato colorato sul supporto stesso. I coloranti sono quasi tutti di natura organica e vengono distinti in naturali (vegetali o animali) e artificiali. Gli utilizzi industriali sono davvero molti, in particolare si possono citare la stampa e la colorazione dei tessuti e dei filati, la colorazione dei prodotti organici, l’utilizzo nella fotografia, nella microscopia e anche in qualità di indicatori. Le categorie di coloranti sono sostanzialmente quattro.
Industria chimica: le caratteristiche dell’europio
 L’industria chimica annovera una serie di elementi metallici di cui si sente parlare molto poco: non a caso, il gruppo in questione è stato ribattezzato da tempo “gruppo delle terre rare”, anche se ultimamente ci sono state delle compagnie e delle banche che hanno puntato su di essi per proporre i loro nuovi strumenti finanziari. Un elemento molto interessante è senza dubbio l’europio, il quale ha numero atomico 63 e peso atomico pari a 152. L’appartenenza al novero menzionato in precedenza è dovuta soprattutto al fatto che si tratta di una delle terre rare meno abbondanti in assoluto di tutti gli altri elementi: ciò nonostante, questo non impedisce che l’europio stesso sia molto volatile, il più volatile in assoluto del gruppo, oltre a rappresentare l’elemento metallico che ha le caratteristiche peculiari più note.
L’industria chimica annovera una serie di elementi metallici di cui si sente parlare molto poco: non a caso, il gruppo in questione è stato ribattezzato da tempo “gruppo delle terre rare”, anche se ultimamente ci sono state delle compagnie e delle banche che hanno puntato su di essi per proporre i loro nuovi strumenti finanziari. Un elemento molto interessante è senza dubbio l’europio, il quale ha numero atomico 63 e peso atomico pari a 152. L’appartenenza al novero menzionato in precedenza è dovuta soprattutto al fatto che si tratta di una delle terre rare meno abbondanti in assoluto di tutti gli altri elementi: ciò nonostante, questo non impedisce che l’europio stesso sia molto volatile, il più volatile in assoluto del gruppo, oltre a rappresentare l’elemento metallico che ha le caratteristiche peculiari più note.
Metalli industriali e terre rare: l’erbio
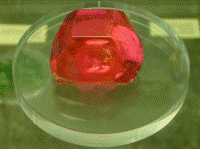 L’erbio è un elemento chimico metallico che fa parte del gruppo delle cosiddette “terre rare”. La sua scoperta si deve a Carl Gustaf Monsander, il quale si accorse della sua esistenza per la prima volta nel 1843, anche se in quella occasione il primo nome affibbiato fu quello di “terbio”. In seguito, a causa di alcune complicazioni che erano sorte in merito alla nomenclature delle stesse terre rare, il nome fu appunto modificato in erbio (siamo nel 1860 per la precisione): c’è comunque da precisare che solamente nel 1878 fu ottenuto l’elemento in questione in una forma che potesse essere considerata pura in maniera ragionevole. In natura, l’erbio si trova diffuso in molti minerali, in particolare nella gadolinite che proviene dai giacimenti di Ytterby, in Svezia, una località da cui ha preso origine sia il primo che il secondo nome dato a tale elemento.
L’erbio è un elemento chimico metallico che fa parte del gruppo delle cosiddette “terre rare”. La sua scoperta si deve a Carl Gustaf Monsander, il quale si accorse della sua esistenza per la prima volta nel 1843, anche se in quella occasione il primo nome affibbiato fu quello di “terbio”. In seguito, a causa di alcune complicazioni che erano sorte in merito alla nomenclature delle stesse terre rare, il nome fu appunto modificato in erbio (siamo nel 1860 per la precisione): c’è comunque da precisare che solamente nel 1878 fu ottenuto l’elemento in questione in una forma che potesse essere considerata pura in maniera ragionevole. In natura, l’erbio si trova diffuso in molti minerali, in particolare nella gadolinite che proviene dai giacimenti di Ytterby, in Svezia, una località da cui ha preso origine sia il primo che il secondo nome dato a tale elemento.

