 La saccarimetria è l’insieme di procedimenti analitici che sono impiegati per la determinazione quantitativa degli zuccheri e del saccarosio a livello industriale: vi sono tre diversi tipi di metodi per porre in essere questo mix di fasi chimico-industriali. Anzitutto, si può cominciare con i metodi areometrici, vale a dire quelli che sono basati sulla temperatura tra la percentuale di zucchero che è contenuto in una data soluzione e il peso specifico di quest’ultima. Per riuscire a determinare il peso specifico , nella pratica industriale si adoperano degli aerometri speciali, i quali sono detti saccarometri, tarati in genere a venti gradi e graduati in modo da indicare direttamente la percentuale in peso di zucchero contenuto nella soluzione in esame (in gradi Balling o in gradi Bix per la precisione).
La saccarimetria è l’insieme di procedimenti analitici che sono impiegati per la determinazione quantitativa degli zuccheri e del saccarosio a livello industriale: vi sono tre diversi tipi di metodi per porre in essere questo mix di fasi chimico-industriali. Anzitutto, si può cominciare con i metodi areometrici, vale a dire quelli che sono basati sulla temperatura tra la percentuale di zucchero che è contenuto in una data soluzione e il peso specifico di quest’ultima. Per riuscire a determinare il peso specifico , nella pratica industriale si adoperano degli aerometri speciali, i quali sono detti saccarometri, tarati in genere a venti gradi e graduati in modo da indicare direttamente la percentuale in peso di zucchero contenuto nella soluzione in esame (in gradi Balling o in gradi Bix per la precisione).
Prodotti industria chimica
Industria chimica: la gomma sintetica Buna-S
 La buna caratterizza da diverso tempo l’industria chimica: si tratta della gomma sintetica che si può ottenere dalla copolimerizzazione del butadiene con lo stirolo o con il nitrile acrilico. Il termine, il quale può sembrare così particolare, non è altro che la fusione tra le due iniziali delle parole Butadiene e Natrium (sodio per l’appunto), vale a dire la materia prima e il catalizzatore che si sfruttano nel processo originale. La buna è posta in commercio in vari sottotipi. Quella di tipo standard, comunque, si ottiene attraverso una copolimerizzazione di settantuno parti di butadiene e ventinove parti di stirolo. Nel corso della preparazione, poi, si aggiunge anche un apposito antiossidante (in genere sotto forma di dispersione): attraverso l’intero procedimento, inoltre, si ricava un lattice speciale, dal quale, per mezzo della coagulazione con l’allume o l’acido amminoacetico o ancora i sali acidi, si consegue la gomma secca.
La buna caratterizza da diverso tempo l’industria chimica: si tratta della gomma sintetica che si può ottenere dalla copolimerizzazione del butadiene con lo stirolo o con il nitrile acrilico. Il termine, il quale può sembrare così particolare, non è altro che la fusione tra le due iniziali delle parole Butadiene e Natrium (sodio per l’appunto), vale a dire la materia prima e il catalizzatore che si sfruttano nel processo originale. La buna è posta in commercio in vari sottotipi. Quella di tipo standard, comunque, si ottiene attraverso una copolimerizzazione di settantuno parti di butadiene e ventinove parti di stirolo. Nel corso della preparazione, poi, si aggiunge anche un apposito antiossidante (in genere sotto forma di dispersione): attraverso l’intero procedimento, inoltre, si ricava un lattice speciale, dal quale, per mezzo della coagulazione con l’allume o l’acido amminoacetico o ancora i sali acidi, si consegue la gomma secca.
Gli impieghi industriali dell’argon
 L’argon è l’elemento chimico, detto anche più semplicemente “argo”, che fa parte dei cosiddetti “gas nobili”: esso si trova in natura come costituente dell’atmosfera di cui rappresenta l’1% in volume. L’ottenimento di questo elemento avviene su larga scala grazie, in particolare, alla distillazione frazionata dell’aria liquida. L’argon, inoltre, tende a bollire a 185,9 gradi, vale a dire a una temperatura che è intermedia tra quelle di ebollizione dell’azoto e dell’ossigeno. Si tratta di un elemento che è inerte dal punto di vista chimico, con una struttura elettronica che è dotata di altissima stabilità, tale da rendere all’argon stesso estremamente difficile la possibilità di legarsi con altri elementi. I suoi utilizzi più pratici si basano proprio sulla proprietà che è stata appena descritta.
L’argon è l’elemento chimico, detto anche più semplicemente “argo”, che fa parte dei cosiddetti “gas nobili”: esso si trova in natura come costituente dell’atmosfera di cui rappresenta l’1% in volume. L’ottenimento di questo elemento avviene su larga scala grazie, in particolare, alla distillazione frazionata dell’aria liquida. L’argon, inoltre, tende a bollire a 185,9 gradi, vale a dire a una temperatura che è intermedia tra quelle di ebollizione dell’azoto e dell’ossigeno. Si tratta di un elemento che è inerte dal punto di vista chimico, con una struttura elettronica che è dotata di altissima stabilità, tale da rendere all’argon stesso estremamente difficile la possibilità di legarsi con altri elementi. I suoi utilizzi più pratici si basano proprio sulla proprietà che è stata appena descritta.
Chimica industriale: i saturatori Fauser e Fassbender
 Col termine saturatore si indicano di solito gli apparecchi che sono atti a produrre saturazione, sia in ambiente aeriforme che liquido: la saturazione a livello industriale si realizza quando un gas, un liquido o un solido disciolti in un solvente raggiungono la massima solubilità nel solvente stesso. Una tipologia molto sfruttata in questo senso è quella del saturatore Fauser per nitrato di ammonio. In pratica, tale apparecchio serve per la produzione di soluzioni sature di questo composto chimico. Al suo interno, infatti, sotto una pressione corrispondente a una certa colonna di liquido, avviene la reazione tra l’ammoniaca e l’acido nitrico.
Col termine saturatore si indicano di solito gli apparecchi che sono atti a produrre saturazione, sia in ambiente aeriforme che liquido: la saturazione a livello industriale si realizza quando un gas, un liquido o un solido disciolti in un solvente raggiungono la massima solubilità nel solvente stesso. Una tipologia molto sfruttata in questo senso è quella del saturatore Fauser per nitrato di ammonio. In pratica, tale apparecchio serve per la produzione di soluzioni sature di questo composto chimico. Al suo interno, infatti, sotto una pressione corrispondente a una certa colonna di liquido, avviene la reazione tra l’ammoniaca e l’acido nitrico.
Industria chimica: come si ottiene l’enocianina
 Quando si parla di enocianina, si fa riferimento a quella sostanza colorante che è contenuta nell’uva nera. In effetti, essa tende a passare nel vino, in cui è contenuta sino a una quota massima dell’1%. L’enocianina, inoltre, fa parte del gruppo degli antociani: tra le caratteristiche principali bisogna menzionare senza dubbio il tipico colore azzurro scuro, oltre al fatto che questa stessa sostanza si separa dal vino attraverso la precipitazione con acetato basico di piombo. L’utilizzo più classico è quello relativo alla colorazione dei vini chiari, dunque l’industria maggiormente coinvolte in questo senso non è solamente quella chimica, ma anche quella enologica.
Quando si parla di enocianina, si fa riferimento a quella sostanza colorante che è contenuta nell’uva nera. In effetti, essa tende a passare nel vino, in cui è contenuta sino a una quota massima dell’1%. L’enocianina, inoltre, fa parte del gruppo degli antociani: tra le caratteristiche principali bisogna menzionare senza dubbio il tipico colore azzurro scuro, oltre al fatto che questa stessa sostanza si separa dal vino attraverso la precipitazione con acetato basico di piombo. L’utilizzo più classico è quello relativo alla colorazione dei vini chiari, dunque l’industria maggiormente coinvolte in questo senso non è solamente quella chimica, ma anche quella enologica.
Prodotti dell’industria chimica: il muschio artificiale
 Forse non tutti sanno che il muschio artificiale rappresenta un composto che fa parte dell’ampia platea di prodotti dell’industria chimica: in effetti, si sta parlando della denominazione che normalmente viene attribuita a vari composti organici e artificiali, in genere nitroderivati e in grado di possedere un odore molto simile a quello del muschio che si può rinvenire in natura. Anche se sono state condotte negli anni diverse e ampie ricerche per trovare composti sempre più pregevoli, quelli che sono maggiormente apprezzati rimangono il muschio xilene, il muschio ambretta e il muschio chetone, i quali sono stati scoperti verso la fine del XIX secolo.
Forse non tutti sanno che il muschio artificiale rappresenta un composto che fa parte dell’ampia platea di prodotti dell’industria chimica: in effetti, si sta parlando della denominazione che normalmente viene attribuita a vari composti organici e artificiali, in genere nitroderivati e in grado di possedere un odore molto simile a quello del muschio che si può rinvenire in natura. Anche se sono state condotte negli anni diverse e ampie ricerche per trovare composti sempre più pregevoli, quelli che sono maggiormente apprezzati rimangono il muschio xilene, il muschio ambretta e il muschio chetone, i quali sono stati scoperti verso la fine del XIX secolo.
Coloranti e pigmenti industriali: l’oltremare
 Uno dei più interessanti prodotti della chimica industriale è senza dubbio l’oltremare, il prodotto che viene utilizzato principalmente come pigmento e colorante: la variante più diffusa in questo senso è quella dell’oltremare azzurro, un colorante che si otteneva in passato dal lapislazzuli naturale sottoposto a polverizzazione, arroventato in maniera leggera e poi trattato con acqua e acido acetico diluito, quindi ulteriormente porfirizzato e levigato con la stessa acqua. Insomma, la lavorazione era piuttosto articolata, ma poi con il tempo si è evoluta. Al giorno d’oggi, infatti, si preferisce calcinare una miscela di caolino, carbonato e solfato sodico, senza dimenticare lo zolfo, il carbone e anche la colofonia e la pace.
Uno dei più interessanti prodotti della chimica industriale è senza dubbio l’oltremare, il prodotto che viene utilizzato principalmente come pigmento e colorante: la variante più diffusa in questo senso è quella dell’oltremare azzurro, un colorante che si otteneva in passato dal lapislazzuli naturale sottoposto a polverizzazione, arroventato in maniera leggera e poi trattato con acqua e acido acetico diluito, quindi ulteriormente porfirizzato e levigato con la stessa acqua. Insomma, la lavorazione era piuttosto articolata, ma poi con il tempo si è evoluta. Al giorno d’oggi, infatti, si preferisce calcinare una miscela di caolino, carbonato e solfato sodico, senza dimenticare lo zolfo, il carbone e anche la colofonia e la pace.
Chimica industriale: il vanadio
 Il vanadio è l’elemento metallico con simbolo V e numero atomico 23 che appartiene alla prima serie dei cosiddetti “metalli di transizione”: il minerale di partenza che impiegato più comunemente per l’estrazione di questo stesso elemento è la carnotite, oltre al vanadato di uranio e il potassio. Come si prepara esattamente dal punto di vista della chimica industriale? Anzitutto, il minerale di partenza viene trattato per trasformare il vanadio in esso contenuto in ossido puro; a tale scopo, il minerale viene sottoposto a triturazione, quindi trattato a caldo con una soluzione di soda. Questa stessa soluzione viene poi estratta con il solvente e il metavanadato sodico. Il sale di ammonio, per effetto del riscaldamento, si trasforma inoltre in pentossido di vanadio. Sono sostanzialmente due i metodi di produzione del vanadio metallico.
Il vanadio è l’elemento metallico con simbolo V e numero atomico 23 che appartiene alla prima serie dei cosiddetti “metalli di transizione”: il minerale di partenza che impiegato più comunemente per l’estrazione di questo stesso elemento è la carnotite, oltre al vanadato di uranio e il potassio. Come si prepara esattamente dal punto di vista della chimica industriale? Anzitutto, il minerale di partenza viene trattato per trasformare il vanadio in esso contenuto in ossido puro; a tale scopo, il minerale viene sottoposto a triturazione, quindi trattato a caldo con una soluzione di soda. Questa stessa soluzione viene poi estratta con il solvente e il metavanadato sodico. Il sale di ammonio, per effetto del riscaldamento, si trasforma inoltre in pentossido di vanadio. Sono sostanzialmente due i metodi di produzione del vanadio metallico.
Refrigerazione industriale: il processo Claude
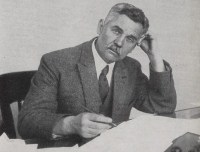 Il processo Claude è un procedimento industriale che prevede come risultato finale la refrigerazione di un determinato gas: volendo essere ancora più precisi, c’è da sottolineare come si tratti del processo che consente di preparare l’ammoniaca attraverso la sintesi di una miscela gassosa che è costituita essenzialmente da idrogeno e azoto in opportune proporzioni. L’utilizzo tipico è quello relativo alla liquefazione dell’aria, di conseguenza la produzione dello stesso azoto e dell’ossigeno diventa determinante da questo punto di vista. La sua nascita può essere fatta risalire al 1902, vale a dire all’anno in cui esso fu inventato dal fisico e imprenditore francese Georges Claude. Tra l’altro, si sta anche parlando di un’alternativa molto valida al cosiddetto processo Linde.
Il processo Claude è un procedimento industriale che prevede come risultato finale la refrigerazione di un determinato gas: volendo essere ancora più precisi, c’è da sottolineare come si tratti del processo che consente di preparare l’ammoniaca attraverso la sintesi di una miscela gassosa che è costituita essenzialmente da idrogeno e azoto in opportune proporzioni. L’utilizzo tipico è quello relativo alla liquefazione dell’aria, di conseguenza la produzione dello stesso azoto e dell’ossigeno diventa determinante da questo punto di vista. La sua nascita può essere fatta risalire al 1902, vale a dire all’anno in cui esso fu inventato dal fisico e imprenditore francese Georges Claude. Tra l’altro, si sta anche parlando di un’alternativa molto valida al cosiddetto processo Linde.
Chimica industriale: il reforming della benzina
 Il reforming è il processo della chimica industriale che ha per obiettivo quello di migliorare le qualità di una benzina: volendo essere ancora più precisi, bisogna sottolineare come si tratti dell’aumento del numero di ottano del carburante stesso. Proprio per questo motivo, il reforming può essere sia termico che catalitico, quindi bisogna capire quali sono le caratteristiche principali in questo senso. Anzitutto, il processo termico consiste in una sorta di piroscissione a cui si sottopone una benzina piuttosto pesante, in modo da riuscire a trasformarla in un composto decisamente più leggero. Il reforming catalitico, al contrario, prevede che vi sia una serie di reazioni che possono essere riassunte in diverse fasi (le più significative sono quelle della cicloversione, dell’ultraforming, del sovaforming e del powerforming).
Il reforming è il processo della chimica industriale che ha per obiettivo quello di migliorare le qualità di una benzina: volendo essere ancora più precisi, bisogna sottolineare come si tratti dell’aumento del numero di ottano del carburante stesso. Proprio per questo motivo, il reforming può essere sia termico che catalitico, quindi bisogna capire quali sono le caratteristiche principali in questo senso. Anzitutto, il processo termico consiste in una sorta di piroscissione a cui si sottopone una benzina piuttosto pesante, in modo da riuscire a trasformarla in un composto decisamente più leggero. Il reforming catalitico, al contrario, prevede che vi sia una serie di reazioni che possono essere riassunte in diverse fasi (le più significative sono quelle della cicloversione, dell’ultraforming, del sovaforming e del powerforming).

