 In genere, la composizione dei semi di cacao decorticati è composta da diversi elementi. Si tratta, anzitutto, dell’acqua (fino al 10%), delle sostanze azotate, quelle grasse, amido e zuccheri, tannino, il rosso di cacao (una speciale sostanza colorante che si forma di solito nei semi più maturi), cellulosa, ceneri, teobromina e caffeina. Anche all’interno dei gusci si trova una composizione altrettanto variegata. Tra l’altro, nelle ceneri di cacao si trova una quantità molto piccola di rame, il quale rappresenta circa lo 0,002% dei semi decorticati e lo 0,02% dei gusci. Come viene effettuata la lavorazione industriale del prodotto?
In genere, la composizione dei semi di cacao decorticati è composta da diversi elementi. Si tratta, anzitutto, dell’acqua (fino al 10%), delle sostanze azotate, quelle grasse, amido e zuccheri, tannino, il rosso di cacao (una speciale sostanza colorante che si forma di solito nei semi più maturi), cellulosa, ceneri, teobromina e caffeina. Anche all’interno dei gusci si trova una composizione altrettanto variegata. Tra l’altro, nelle ceneri di cacao si trova una quantità molto piccola di rame, il quale rappresenta circa lo 0,002% dei semi decorticati e lo 0,02% dei gusci. Come viene effettuata la lavorazione industriale del prodotto?
 Redazione
Redazione
Impianti industriali: come funzionano le saline
 La salina è una zona di terreno che viene preparata per l’evaporazione e la cristallizzazione frazionata di acqua salata, in genere acqua marina, da cui si ricava principalmente cloruro di sodio (appunto il sale) per effetto dell’azione del calore solare e del vento. Le saline occupano delle estensioni molto elevate di terreno pianeggiante, divise in vari ordini di vasche o bacini, i quali determinano due gruppi di superfici: uno è quello evaporante (bacini di evaporazione o caselle servitrici) e l’altro salante (caselle salanti). Nel primo caso si compie la concentrazione delle acque fino a renderle sature di cloruro di sodio, mentre nel secondo si effettua la separazione del sale.
La salina è una zona di terreno che viene preparata per l’evaporazione e la cristallizzazione frazionata di acqua salata, in genere acqua marina, da cui si ricava principalmente cloruro di sodio (appunto il sale) per effetto dell’azione del calore solare e del vento. Le saline occupano delle estensioni molto elevate di terreno pianeggiante, divise in vari ordini di vasche o bacini, i quali determinano due gruppi di superfici: uno è quello evaporante (bacini di evaporazione o caselle servitrici) e l’altro salante (caselle salanti). Nel primo caso si compie la concentrazione delle acque fino a renderle sature di cloruro di sodio, mentre nel secondo si effettua la separazione del sale.
Terre rare: come l’industria impiega il samario
 Il samario è uno degli elementi che fa parte delle famiglia delle cosiddette “terre rare”. Il numero atomico è il 62, mentre il peso atomico è 150,4, senza dimenticare che il simbolo identificativo è Sm. Esso è stato ottenuto per la prima volta in forma pura nel lontano 1901: al giorno d’oggi, invece, i suoi composti trivalenti (il samario ha delle interessanti caratteristiche e proprietà metalliche) possono essere facilmente separati dai sali delle altre terre rare, il tutto attraverso una cromatografia a scambio ionico. L’ossido di samario si scioglie in maniera piuttosto agevole negli acidi, dando vita a una serie di sali che vengono di solito impiegati come scintillatori fotosensibili nella regione spettrale del rosso e dell’infrarosso.
Il samario è uno degli elementi che fa parte delle famiglia delle cosiddette “terre rare”. Il numero atomico è il 62, mentre il peso atomico è 150,4, senza dimenticare che il simbolo identificativo è Sm. Esso è stato ottenuto per la prima volta in forma pura nel lontano 1901: al giorno d’oggi, invece, i suoi composti trivalenti (il samario ha delle interessanti caratteristiche e proprietà metalliche) possono essere facilmente separati dai sali delle altre terre rare, il tutto attraverso una cromatografia a scambio ionico. L’ossido di samario si scioglie in maniera piuttosto agevole negli acidi, dando vita a una serie di sali che vengono di solito impiegati come scintillatori fotosensibili nella regione spettrale del rosso e dell’infrarosso.
Chimica industriale: le particolarità della gomma butile
 La gomma butile è una gomma sintetica che si ottiene dalla copolimerizzazione di due elementi, l’isobutilene e l’isoprene. Nel primo caso, la polimerizzazione consente di ottenere dei prodotti che sono privi di doppi legami e di conseguenza non vulcanizzabili. Andando ad aggiungere l’isoprene in quantità molto piccole (dall’1,5 al 4,5% per la precisione) si riesce a superare brillantemente questo ostacolo. In effetti, le catene che si ottengono in tale maniera sono caratterizzate da molecole di isobutilene che vengono intervallate ogni tanto da una di isoprene.
La gomma butile è una gomma sintetica che si ottiene dalla copolimerizzazione di due elementi, l’isobutilene e l’isoprene. Nel primo caso, la polimerizzazione consente di ottenere dei prodotti che sono privi di doppi legami e di conseguenza non vulcanizzabili. Andando ad aggiungere l’isoprene in quantità molto piccole (dall’1,5 al 4,5% per la precisione) si riesce a superare brillantemente questo ostacolo. In effetti, le catene che si ottengono in tale maniera sono caratterizzate da molecole di isobutilene che vengono intervallate ogni tanto da una di isoprene.
Industria metallurgica: la loppa d’altoforno
 Con il termine loppa si indicano di solito nell’industria metallurgica le scorie che vengono prodotte dall’altoforno in contemporanea alla ghisa: la composizione di questa loppa dipende essenzialmente dalla qualità effettiva e dalla proporzione dei minerali e dei fondenti che vanno a costituire la carica dell’altoforno stesso, oltre che dalla marcia (calda o fredda non ha alcuna importanza) di quest’ultimo. Le loppe, con riferimento al loro utilizzo industriale, si possono suddividere in due distinte categorie: anzitutto, possiamo avere a che fare con le loppe acide, dette anche “lunghe”, e le loppe neutre.
Con il termine loppa si indicano di solito nell’industria metallurgica le scorie che vengono prodotte dall’altoforno in contemporanea alla ghisa: la composizione di questa loppa dipende essenzialmente dalla qualità effettiva e dalla proporzione dei minerali e dei fondenti che vanno a costituire la carica dell’altoforno stesso, oltre che dalla marcia (calda o fredda non ha alcuna importanza) di quest’ultimo. Le loppe, con riferimento al loro utilizzo industriale, si possono suddividere in due distinte categorie: anzitutto, possiamo avere a che fare con le loppe acide, dette anche “lunghe”, e le loppe neutre.
Gli errori più comuni nelle verniciature
 L’impiego non corretto delle vernici industriali può produrre come risultato una superficie piena di difetti. Gli errori tipici in questo caso sono diversi, ma possono essere evitati facilmente, in particolare dopo avere individuato le cause che li hanno provocati. Uno strato di vernice di spessore non uniforme, ad esempio, può dipendere dal prodotto che è troppo vecchio o dalla temperatura dell’ambiente di lavoro, superiore ai trenta gradi centigradi o inferiore ai diciotto: in alternativa, tutto questo può essere causato anche dalle correnti d’aria oppure dalla esposizione fin troppo diretta ai raggi del sole.
L’impiego non corretto delle vernici industriali può produrre come risultato una superficie piena di difetti. Gli errori tipici in questo caso sono diversi, ma possono essere evitati facilmente, in particolare dopo avere individuato le cause che li hanno provocati. Uno strato di vernice di spessore non uniforme, ad esempio, può dipendere dal prodotto che è troppo vecchio o dalla temperatura dell’ambiente di lavoro, superiore ai trenta gradi centigradi o inferiore ai diciotto: in alternativa, tutto questo può essere causato anche dalle correnti d’aria oppure dalla esposizione fin troppo diretta ai raggi del sole.
La corretta e regolare manutenzione della pialla
 La pialla fa parte di quel gruppo di strumenti industriali che richiedono una maggiore cura e manutenzione. Sono diversi gli accorgimenti che vanno ricordati, in modo da porli in essere con regolarità. Anzitutto, è necessario strofinare a cadenza periodica (ad esempio tre mesi) con l’olio di lino o l’olio di lino cotto con il ceppo. Si tratta di oli che si possono rinvenire con una certa semplicità in farmacia, utili anche se utilizzati sul banco su cui si va a piallare. Lo stesso discorso deve essere fatto per il ferro e il controferro, bisognosi di una goccia di olio ogni tanto: lo scopo è presto detto, dato che si vuole impedire l’arrugginimento, in particolare nel caso di debba lavorare in cantina o in un ambiente piuttosto umido.
La pialla fa parte di quel gruppo di strumenti industriali che richiedono una maggiore cura e manutenzione. Sono diversi gli accorgimenti che vanno ricordati, in modo da porli in essere con regolarità. Anzitutto, è necessario strofinare a cadenza periodica (ad esempio tre mesi) con l’olio di lino o l’olio di lino cotto con il ceppo. Si tratta di oli che si possono rinvenire con una certa semplicità in farmacia, utili anche se utilizzati sul banco su cui si va a piallare. Lo stesso discorso deve essere fatto per il ferro e il controferro, bisognosi di una goccia di olio ogni tanto: lo scopo è presto detto, dato che si vuole impedire l’arrugginimento, in particolare nel caso di debba lavorare in cantina o in un ambiente piuttosto umido.
Le vernici al poliuretano e alla nitrocellulosa
 Tra le vernici industriali che meritano un approfondimento figurano senza dubbio quelle al poliuretano e quelle alla nitrocellulosa. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. Le vernici al poliuretano fanno parte del gruppo delle vernici reattive e si caratterizzano per i due tipici componenti che devono essere mescolati in una determinata proporzione, immediatamente prima del loro impiego. Dopo aver effettuato il mescolamento in questione, il prodotto può essere utilizzato solamente per poche ore, vale a dire prima che indurisca.
Tra le vernici industriali che meritano un approfondimento figurano senza dubbio quelle al poliuretano e quelle alla nitrocellulosa. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. Le vernici al poliuretano fanno parte del gruppo delle vernici reattive e si caratterizzano per i due tipici componenti che devono essere mescolati in una determinata proporzione, immediatamente prima del loro impiego. Dopo aver effettuato il mescolamento in questione, il prodotto può essere utilizzato solamente per poche ore, vale a dire prima che indurisca.
Isole Salomone: i progetti israeliani per il nuovo parco industriale
 Un team della compagnia israeliana Goldtec Control Systems si è recato nei giorni scorsi in visita presso le Isole Salomone. In effetti, i due proprietari del gruppo in questione, Meir e Anat Goldstein, sono stati incaricati dal governo di Gerusalemme di prendere spunto dallo stabilimento della prima Israeli Demonstration Farm nel paese oceaniano, in modo da dare vita al progetto del Kadabina Industrial Park. I Goldstein hanno appunto visitato il sito in questione e incontrato i proprietari terrieri, oltre agli amministratori fiduciari. Il progetto coinvolge circa trentanove ettari di terreno, ma in questo momento è importante soprattutto riallocare le abitazioni e un istituto scolastico all’interno dell’area.
Un team della compagnia israeliana Goldtec Control Systems si è recato nei giorni scorsi in visita presso le Isole Salomone. In effetti, i due proprietari del gruppo in questione, Meir e Anat Goldstein, sono stati incaricati dal governo di Gerusalemme di prendere spunto dallo stabilimento della prima Israeli Demonstration Farm nel paese oceaniano, in modo da dare vita al progetto del Kadabina Industrial Park. I Goldstein hanno appunto visitato il sito in questione e incontrato i proprietari terrieri, oltre agli amministratori fiduciari. Il progetto coinvolge circa trentanove ettari di terreno, ma in questo momento è importante soprattutto riallocare le abitazioni e un istituto scolastico all’interno dell’area.
Archeologia industriale: l’edizione 2013 di EXAREA
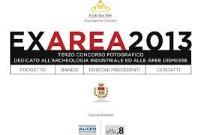 Le fotografie sono senza dubbio fondamentali per dare risalto al patrimonio industriale e ai mutamenti a cui è stato interessato: gli scatti, infatti, consentono di indagare più a fondo su un argomento delicato come quello della riconversione dell’ex aree industriali e di quelle che sono state dismesse. È proprio per questo motivo che da due anni esiste un progetto chiamato Exarea, fortemente voluto dall’associazione culturale Feudo Ron Alfrè, la quale ha sede a Bellizzi (ci troviamo in provincia di Salerno per la precisione). Inizialmente, si è trattato soprattutto dell’organizzazione di un concorso fotografico che fosse dedicato all’archeologia industriale, ma poi nei vari anni tutto questo si è evoluto.
Le fotografie sono senza dubbio fondamentali per dare risalto al patrimonio industriale e ai mutamenti a cui è stato interessato: gli scatti, infatti, consentono di indagare più a fondo su un argomento delicato come quello della riconversione dell’ex aree industriali e di quelle che sono state dismesse. È proprio per questo motivo che da due anni esiste un progetto chiamato Exarea, fortemente voluto dall’associazione culturale Feudo Ron Alfrè, la quale ha sede a Bellizzi (ci troviamo in provincia di Salerno per la precisione). Inizialmente, si è trattato soprattutto dell’organizzazione di un concorso fotografico che fosse dedicato all’archeologia industriale, ma poi nei vari anni tutto questo si è evoluto.

